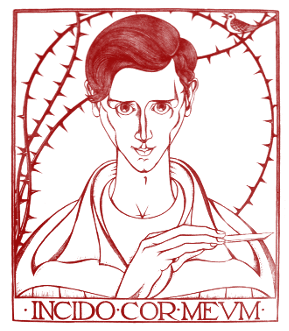Un istante mi porta
insensibilmente a un altro e
il tema atematico si sviluppa
senza piano ma geometrico
come le figure successive
in un caleidoscopio.
Clarice Lispector
Acqua viva
La Bella Addormentata preferisce ignorare le lusinghe di una felice vita matrimoniale con il Principe Azzurro, e invece di arrendersi a un prevedibilmente noioso lieto fine, sceglie di avventurarsi sempre più addentro nel mondo dei sogni. Un mondo nel quale, tanto per cominciare, assume con disinvoltura una più comoda identità maschile, mentre i genitori le appaiono in guisa di patetici feticci: tacchi alti, bambola di pezza, porcellino-salvadanaio… Forse è meglio non indagare sulla promiscuità che vige nei rapporti fra Biancaneve e i sette nani, e nemmeno sui torbidi motivi che spingono i genitori di Hansel e Gretel ad abbandonare i figli nel bosco, ma se da questa lettura delle favole non è più possibile dedurre una morale rassicurante, bisognerà pur decidersi a trarne una lezione: «gli scrittori di favole ci stavano avvertendo di cose terribili che possono accadere».
Che le favole, con i loro inquietanti bestiari e i vertiginosi aneddoti, non fossero giochi inoffensivi per bambini ancora privi di playstation, ma (fra l’altro) una formidabile risorsa per sovvertire il canone letterario ufficiale della narrativa latinoamericana, era risultato chiaro fin dagli esordi di Augusto Monterroso: il dinosauro del celebre microracconto1 era in fin dei conti un gustoso anticipo (il libro è del 1959) delle sue successive incursioni nel mondo animale. Il discorso critico di Monterroso si preciserà poi negli anni Settanta, a partire dalla pubblicazione di La pecora nera e altre favole, sarà sistematizzato nelle interviste raccolte in Viaje al fondo de la fabula (1981) e troverà la formulazione più cristallina in Moto perpetuo. Qui, come annota Dante Llano, «l’autore delle favole elimina l’aneddoto e riduce il meccanismo narrativo alla consequenzialità del linguaggio; in tal modo, non c’è tema che non possa essere considerato letterario o, paradossalmente, non vi sono temi letterari»2. In Moto perpetuo, infatti, Monterroso decretava con il suo imperturbabile humour: «Ci sono tre temi: l’amore, la morte e le mosche […] io mi occupo delle mosche».
Sena pretendere in poche righe di fare un bilancio dell’importanza della sua opera – pur esigua per numero di titoli e di pagine –, si vuol dire che la sua esplorazione dei generi ibridi, dei meccanismi che li reggono, delle frontiere (permeabili, o elastiche) che li delimitano, la radicale messa in discussione della funzione autoriale, il ricorso alla metanarrazione e a una modalità peculiare della parodia,3 hanno aperto spazi impensati di libertà creativa per gli scrittori delle generazioni successive che ne hanno accolto la lezione. Scrittori, inutile dirlo, che percorrevano sentieri meno affollati di quelli seguiti dagli epigoni della generazione del cosiddetto “boom”. Oggi, nonostante la relativa scarsità di studi critici a lui dedicati, si può riconoscere agevolmente l’efficacia del suo magistero, soprattutto in Messico – dove trascorse buona parte dell’esilio –, ma anche in patria, come testimonia la recente pubblicazione di diversi testi, soprattutto di scrittrici.4 Lo segnala la poetessa Aida Toledo in un saggio nel quale esamina la recente letteratura guatemalteca: «La narrativa femminile negli ultimi decenni del XX secolo si situa di solito sulla frequenza del racconto breve e si ritrova a dialogare soprattutto con i testi di Augusto Monterroso, in relazione ai toni epigrammatici e all’ibridismo dei generi».5 (La Toledo lamenta invece l’assenza, nel periodo preso in esame, e sempre riferendosi alle narratrici, di tematiche analoghe a quelle presenti nella letteratura di Clarice Lispector, che scavino dal di dentro le tematiche dell’atto della scrittura, salvo fare un’eccezione proprio per la Gallardo.)
Anche una studiosa italiana, Emilia Perassi, presentando una stimolante raccolta di studi sulla recente letteratura femminile iberica e ispanoamericana, ci aveva avvertiti: «Agita dunque dalla voce dell’“io” e simultaneamente da quella del “tu”, tale letteratura – come in generale tutte le periferiche, le marginali, le sradicate – vive di una peculiare simbiosi col suo necessario passato, giacché forzatamente (le organiche ragioni delle filiazioni estetiche), ma anche gustosamente (le scrittrici non esitano a dichiarare passione straordinaria per i maestri, meno per le maestre, della scrittura), ad esso bisogna ritornare, in quanto sede della propria storia, seppur inadeguata».6
In effetti, da Non affrettarti a raggiungere la Torre di Londra perché la Torre di Londra non è il Big Ben, della guatemalteca Eugenia Gallardo, emergono indizi di un’indubbia filiazione estetica e di un’evidente passione per Monterroso. Intanto, l’autrice condivide il culto del maestro per la narrativa breve, frammentaria, allusiva: ultima barricata contro l’invasività dell’informazione ed efficace antidoto alla tentazione del romanzo totalizzante, e forse per questo prediletta da diverse scrittrici votate a un «progetto di scrittura erratica e intimista».7 E ne condivide altresì la presa di distanza da un’idea di letteratura appiattita su pedagogie politiche di illuministica memoria, a favore di una strategia sovversiva sotterranea, obliqua, ironica, dove il patto con il lettore si stabilisce sulla base di una complicità cameratesca che non esclude qualche sgambetto, ma non maschera certo la presunzione di impartire lezioni ex cathedra. Anche nel libro della Gallardo poi, come nell’ultima produzione di Monterroso, l’aneddoto – sovente mero pretesto – finisce per dileguarsi, lasciando il posto a pure concrezioni di stati d’animo, epifanie emotive riscattate dallo scrigno della memoria, intime e pure così universali. E come in Il resto è silenzio: la vita e l’opera di Eduardo Torre, del maestro, gli elementi autobiografici in Non affrettarti… – molteplici, pudicamente dissimulati ma disseminati in tutto il testo e presenti persino nella materia linguistica, laddove l’autrice non esita a adottare personalissime espressioni della nonna – affiorano senza eccessiva drammaticità e si stemperano e si confondono nell’invenzione letteraria, consentendole di sfuggire anche ai confini del genere biografico, che si dissolvono in un’ironia effervescente.
Come scrive ancora con acutezza Aida Toledo nel saggio già citato, nel tentativo di dare una risposta all’interrogazione con cui l’autrice si congeda dai lettori: «A chi abbia avuto la pazienza di leggermi fin qui, con ordine, domando: Che cos’è quel che ho fatto?», una definizione calzante per Non affrettarti… potrebbe essere Kunstlerroman, ovvero la storia dello sviluppo di un artista. Infatti, una delle possibili trame sottostanti al libero fluire di personaggi, vicende e immagini, insieme al viaggio picaresco a Londra (città dove l’autrice ha effettivamente trascorso un periodo del suo esilio), è proprio quella dello sviluppo delle aspirazioni artistiche letterarie della “«signora scrittrice di questo libro», rivelate nel capitolo 18 (p. 47) dal suo alter ego Carmela, insieme ai loro umanissimi risvolti di vanità. Ricordiamo che il primo libro di Monterroso (Opere complete e altri racconti) ironizzava fin dal titolo sulla vanità del “giovane scrittore”, che desidererebbe veder pubblicate quelle Opere Complete che esistono solo nelle sue velleitarie ambizioni. Mi pare che ci siano elementi a sufficienza per riconoscere una piena consonanza di sensibilità.
Bisogna aggiungere, peraltro, che il dialogo della Gallardo con gli scrittori guatemaltechi delle generazioni precedenti – di cui si possono cogliere svariati, fugaci accenni in Non affrettarti… –, pur privilegiando Monterroso non tralascia altre figure chiave, prima fra tutte quella del premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Né potrebbe essere diversamente, visto che questo autore occupa da solo, per l’estensione, le ramificazioni e le implicazioni della sua opera, l’intero orizzonte letterario nazionale: dal suo primo libro, Leggende del Guatemala, del 1930, a Il Signor Presidente, uno dei più bei romanzi latinoamericani incentrati sulla figura del dittatore, dalla cosiddetta trilogia bananera dei romanzi di denuncia del colonialismo a Mulatta senza nome, del 1963, fino ai testi “minori”,9 Asturias non ha mai smesso di credere nella missione dell’intellettuale di forgiare (o demolire) miti, e la sua presenza nella cultura del paese, sia pure offuscata in passato da furibonde polemiche,10 è tuttora ineludibile (anche perché in qualche misura è riuscito nel suo intento). Asturias, come è noto, in Uomini di mais (1949) aveva ripreso il mito cosmogonico del Popol Vuh, il testo sacro dei maya, circa il ruolo del mais nella creazione dell’uomo. Scrive in proposito Arturo Arias: «Nel Popol Vuh si racconta che gli uomini furono fatti di mais e si spiega, nel mito sull’origine del mais, perché l’agricoltura ha un carattere sacro. Asturias ricorre per la sua opera proprio a questi elementi, difendendoli e trasformandoli in una rivendicazione di identità. Finalmente, è riuscito a trovare l’“anima nazionale”».11 E di seguito riporta le parole di un’altra studiosa, Perla Petrich, secondo la quale l’oggetto mais circola nel romanzo entro due spazi assiologici, quello degli indios e quello dei ladini: nel primo è fondamento di ogni credenza, «il segno della razza, ciò che identifica il gruppo definendolo come unità etnica e come universo culturale. Nel caso dei ladini, al mais vengono negati questi valori “mitici” e lo si riduce a una cosa che ha un valore puramente commerciale, priva di valore simbolico-sociale».
Ebbene, rileggendo il capitolo 6 di Non affrettarti… (p. 17), dove si narra dell’invenzione del popcorn per opera di un nero di New Orleans, si può cogliere il malinconico disincanto e l’affettuosa ironia con cui Eugenia Gallardo ripropone quel conflitto culturale, attualizzandolo nell’epoca della cosiddetta globalizzazione, e il modo in cui riformula l’interrogativo circa l’identità dell’“anima nazionale” al centro delle preoccupazioni di Asturias. Un’“anima nazionale”, non è superfluo ricordarlo, tragicamente lacerata dalla guerra civile e dai massacri degli anni Ottanta.12 Mirabile la “ricetta” dell’autrice: «Signor giardiniere, le risparmierò ore di esperimenti e mi risparmierò secoli di torture: tirarmi fuori l’anima non è difficile, si tratta di darmi molto amore, ma tanto, tanto, intensamente, senza lasciarmi il tempo di pensare né di fuggire e nemmeno di respirare. Il calore intenso di quell’amore mi farà scoppiare di felicità e la mia anima esalerà per la gioia di chi vorrà gustarmi libera da questo guscio protettivo». L’appello all’amore universale, del resto, era anche l’unica speranza di salvezza già additata da Asturias in Mulatta senza nome.
Quanto al gusto per la rivisitazione di cosmogonie più o meno fantastiche, si può tornare al capitolo 26 di Non affrettarti… (p. 65), al racconto di quale fu «l’origine delle nostre origini», dove entrano in scena «i primi esseri viventi»: una variante onirica e ludica dei capitoli del Popol Vuh dedicati alla nascita dell’uomo. Il consiglio finale impartito dalla madre: «è meglio che diate retta al prete, alla maestra, allo psicologo e alla monaca quando vi racconteranno questa stessa storia distorta da altre storie», sembra alludere sornionamente a una trasmissione (orale e femminile) di conoscenze ancestrali disposta a sfidare i secoli e le culture dei successivi conquistatori. Rigoberta Menchu ne ha dato una preziosa testimonianza proprio per quanto concerne le popolazioni maya del Guatemala.13
C’è infine un altro dialogo sommesso che affiora in alcuni capitoli di Non affrettarti…: quello con la letteratura militante e testimoniale. Sarà utile ricordare che, almeno a partire dal golpe che mise termine al governo democratico di Jacopo Arbenz Guzmán (1952-1954), il tema della violenta estromissione delle forze popolari e delle etnie indigene dai processi di modernizzazione del paese, insieme alla denuncia del ruolo svolto in tal senso dalla politica delle amministrazioni statunitensi, è stato spesso al centro delle narrazioni di gran parte degli autori guatemaltechi. È sorta così una forte corrente di letteratura politicamente impegnata, e a un certo punto, con lo sviluppo della guerriglia, l’impegno è venuto a coincidere per molti scrittori con l’arruolamento nelle sue fie. Basterà ricordare la figura di Mario Payeras (1940-1992), che fu membro della Direzione nazionale dell’Egp (Ejército Guerrillero de los Pobres) e che ha riversato nei suoi romanzi le esperienze della militanza sulle montagne e poi nella capitale; o il romanzo Los compañeros (1976), di Marco Antonio Flores, una sofferta radiografia degli errori delle organizzazioni guerrigliere e dello stato d’animo di chi se ne staccava, deluso. Ma si può fare un passo indietro e accennare a Mario Monteforte Toledo. Appartenente dal punto di vista cronologico alla cosiddetta Generazione del 30, e come Asturias e Monterroso esiliato in Messico, aveva svolto un’analisi altrettanto impietosa della sinistra guatemalteca quasi vent’anni prima, nel 1957, con Una manera de morir.
Di un suo racconto – figura nella raccolta La isla de la navaja, del 1993, e inquadra la figura del boia, «così familiare nelle società del Terzo mondo», secondo le malinconiche parole dell’autore – mi è parso di trovare un’eco nel capitolo 10 di Non affrettarti… (p. 27), uno dei più tesi e vibranti, dove si respira l’atmosfera che ha avvelenato per decenni la società guatemalteca: «Perché il boia non lascia mai eredi, se ne va con il sacco della vita ben chiuso senza spargere semi e così è più libero della sua vittima che lascia una vedova, che lascia un orfano, che lascia un seme affinché fioriscano nuove vittime e collezionino foto e rendano testimonianze e cantino sofferenze e lottino contro l’oblio e innalzino monumenti e si riuniscano in commemorazioni strazianti. Dov’è la vedova del boia? Dove sono i suoi nipoti, dove sono gli eredi, dov’è la memoria, chi alza la voce per dire fu mio padre ad accendere gli odi, fu mio nonno a tracciare il percorso della polvere da sparo, fu mia madre quella che…».
Pur non iscrivendosi nel filone della letteratura “impegnata”, e senza rivendicare nemmeno posizioni femministe radicali, il testo della Gallardo, attraversato dalle cicatrici dell’esilio, dispiega sottili strategie discorsive che non lasciano intatto nessuno dei pilastri su cui si fonda una società violenta, nella quale operano feroci discriminazioni e consolidati pregiudizi. Ma lo fa senza situarsi in un preciso contesto storico di riferimento, senza aprire il doloroso registro delle testimonianze, e soprattutto senza assumere la tremenda seriosità maschile prevista in questi casi – quella, per intenderci, di certi “saggi” di cui «fu dimostrato che il filo del loro ragionamento era perfetto, com’erano perfette le loro mani che si alzavano per incitare le masse, com’era perfetto il loro modo di usare il microfono e perfetta la dizione e perfetto il completo che sfoggiavano su un balcone perfetto appena dipinto per far effetto» (p. 56). Accade così che quello che potremmo chiamare lo “shock della globalizzazione” – l’amara scoperta che ogni rapporto umano è rigidamente regolato da forme di scambio monetarie – si risolve nel conflitto linguistico surreale di Carmela con la venditrice di mele londinese del capitolo 13 (p. 34); e il crudele perbenismo borghese è fustigato quasi en passant nel racconto delle disavventure amorose di Betty la bruca (p. 53).
C’è comunque un punto in cui la Gallardo sembra prendere criticamente le distanze, con sguardo retrospettivo, dalle scelte compiute da tanti scrittori e intellettuali: «Trascinarsi a piedi scalzi per seguire una comitiva che prima o poi sarebbe finita in prigione? Carmela decise che quel progetto non le apparteneva» (p. 40). E in fondo, il titolo stesso dell’opera chiarisce l’equivoco iniziale del personaggio di Carmela: la Torre di Londra è un carcere, e non un simbolo di libertà – per questo la comitiva in cammino non si affretta –, e l’autrice giunge all’amara conclusione che l’esilio «è prospettiva migliore di una terra incarcerata» (p. 96).
Peraltro, malgrado gli stretti vincoli con la storia letteraria (e non solo) guatemalteca a cui si è accennato per sommi capi, qualcuno ha potuto scrivere, in modo un po’ paradossale ma indubbiamente suggestivo, che Non affrettarti… «potrebbe essere stato scritto a Zurigo agli inizi del Novecento».14 L’allusione al dadaismo («ma senza la sua insolenza»), che con qualche precauzione si potrebbe estendere anche al surrealismo, non è affatto peregrina, per svariati motivi. Anzitutto, come è noto, questi movimenti artistici hanno avuto una attenta e prolungata ricezione nel continente americano, dove hanno trovato un terreno oltremodo favorevole per svilupparsi. E non sono un segreto i profondi legami fra la poetica surrealista e la nascita del “realismo magico”.15 Senza cercare esempi troppo lontano: Asturias fece esperimenti di scrittura automatica – appresa negli anni Venti a Parigi, mentre aveva la rivelazione dell’identità maya seguendo i corsi di antropologia di Georges Raynaud alla Sorbona – nei suoi primi testi, e ancora in Mulatta senza nome, che è assai più tardo; Eugenia Gallardo, dal canto suo, ha conosciuto e praticato questo metodo frequentando un laboratorio di scrittura creativa.
Un tratto che segnala in modo inequivocabile l’affinità di Non affrettarti… con le avanguardie storiche europee è l’appropriazione e la particolare distorsione delle modalità del discorso infantile – la ripetizione cantilenante, il botta-e-risposta, il nonsense, ecc. – e l’esaltazione del “pensiero magico” infantile, che spezza i meccanismi della logica, abolisce le frontiere fra la realtà e la fantasia e si presenta dunque come spazio privilegiato della creazione artistica. Sicché si può usare un tacchino per farsi trasportare a Londra, invece di un più comodo tappeto volante, ed è possibile cambiare scenario e personaggi a volontà; persino sbarazzarsene, quando osano prendersi libertà di parola, come succede alla povera Carmela, che «non poté sopportare il freddo dell’Alaska. Morì un 25 novembre alle 23.35» (p. 46). La prossimità alla poetica surrealista – sia pure spogliata degli aspetti “luciferini” e depurata dalle più dogmatiche incrostazioni psicoanalitiche16 – risulta soprattutto evidente nei capitoli finali del libro, laddove l’autrice, dopo aver dichiarato: «Mi avanzano cinque immagini che non mi dicono nulla» (p. 108), le illustra e poi tenta di decifrarle; si tratta del tipico procedimento di interrogazione dell’inconscio messo a punto dai surrealisti. Non affrettarti… è senz’altro un testo complesso, al di là dell’apparente facilità con cui si lascia accostare, per la particolare struttura compositiva e perché sollecita varie letture, secondo diverse angolazioni – biografica, estetica, critica, psicoanalitica… – nel momento stesso in cui le chiama in scena per licenziarle seccamente o ironicamente: «Mi sono lasciata guidare dalla ragione, amica della critica. Ma fra tutt’e due, con i loro voraci raggi X, hanno distrutto l’avvenire di questa favola. […] Qualcuno mi ha consigliato di rivolgermi al subconscio. Non sono riuscita a intendermi con lui, è insidioso, ingannevole e imbroglione, ha un linguaggio confuso che lui chiama simbolico e io infondato» (p. 74).
L’abilità dell’autrice consiste nello spiazzare di volta in volta il punto di vista che ha offerto inizialmente al lettore invitandolo ad accomodarsi nelle forme accoglienti di un “genere”: la favola, il diario, il racconto breve… E come Monterroso con Moto perpetuo aveva rivendicato la creazione di un nuovo genere, il sottotitolo dell’opera della Gallardo, “Almanacco”, muove nella stessa direzione. Con una differenza significativa, però: mentre l’innovazione del maestro «consiste in parte nell’esagerare la capacità sinottica del testo»,17 si direbbe che la Gallardo, con la sua predilezione per l’anticlimax, intenda quasi minimizzarne la portata: in fondo sono solo fantasticherie, sembra suggerire, divagazioni.
Forse ciò ha di nuovo a che vedere con il fatto che ci troviamo dinanzi a una scrittrice, per di più molto sensibile a tutte le dimensioni e le sfumature della parola e del linguaggio, nonché alle implicazioni del gesto della scrittura: «Che si fa con la parola che una volta detta non torna più indietro? Con la parola che fece male, quella che forse uscì pura ma venne insudiciata dall’ambiente e tutti gli sguardi accusarono chi l’aveva pronunciata? Siamo arrivati a un momento cruciale del nodo della colpa. E siccome al centro del nodo c’è la parola, mi lego la lingua che la dice, mi amputo la mano che la scrive, paralizzo il cervello che la elabora…» (p. 51). Per sfuggire a questa afasia c’è bisogno di «Una parola che non è voce, né eco, né ricordo, né testo di canzone, né il filo narrativo della storia con una logica, agenda e calendario. Una parola disinvolta e capricciosa. Oggi tamburo, domani flauto con basso e senza trombe» (p. 95).
Una parola, dunque, che tronca «il nodo della colpa» con l’assoluzione già pronunciata da Rimbaud nella celebre Lettre du Voyant: «Poiché Io è un altro. Se l’ottone si sveglia tromba, non è affatto colpa sua».
La consapevolezza dell’atto della scrittura rimanda a un ultimo accostamento, a cui si è già accennato: quello con Clarice Lispector. «Questo che ti scrivo è in contralto. È negro-spirituale. Ha coro e candele accese. Adesso ho una vertigine. Sento un po’ di paura. A cosa mi porterà la mia libertà. Cos’è questo che ti scrivo?» Non può sfuggire, a parte la somiglianza quasi letterale dell’interrogativo finale di questo passo di Acqua viva, della scrittrice brasiliana, con quello dell’Epilogo di Non affrettarti…, la comune preoccupazione per il destino della creazione artistica, che coincide con quello esistenziale dell’autrice. Perché, se la vita è un collage di rebus che siamo chiamati a decifrare se vogliamo restituirle un senso, le parole di cui ci serviremo, per quanto libere e gioiose, non saranno mai un gioco privo di conseguenze. Come scrive ancora la Lispector nello stesso testo: «Chiunque mi accompagni: la strada è lunga, è sofferta ma è vissuta. Perché adesso ti parlo sul serio: non gioco con parole. Mi incarno nelle frasi voluttuose e inintelligibili che si aggomitolano al di là delle parole. E un silenzio si invola sottile dall’urto delle frasi tra loro. […] Ti scrivo in disordine, lo so bene. Ma è come vivo. Io lavoro solo con quello che trovo e con quello che perdo». Credo che gli stessi “intenti programmatici” abbiano guidato Eugenia Gallardo nell’avventura di Non affrettarti…, e il lettore che l’ha accompagnata fino alla fine, di volta in volta sconcertato, divertito, affascinato, forse urtato, avverte di aver ascoltato una parola intima, sofferta, fatta della stessa materia dei sogni e dei desideri, e come questi così profondamente compenetrata nella vita.
Note
- «Quando si svegliò, il dinosauro era ancora lì.» Pubblicato in Opere complete e altri racconti, nel 1959. I titoli delle opere di Monterroso, Asturias, ecc. di cui esiste traduzione italiana sono riportati in italiano per facilitarne l’identificazione, altrimenti figurano nell’originale. Le traduzioni delle citazioni sono mie.
- Dante Llano, Visión crítica de la literatura guatemalteca, 1998. Dante Llano è uno scrittore guatemalteco che risiede da più di vent’anni in Italia. Oltre a importanti studi di critica letteraria (fra gli altri, La palabra y el sueño. Literatura y sociedad en Guatemala, 1984), ha pubblicato romanzi (fra cui Il mistero di san Andrés e L’uomo di Montserrat, ambientato nell’omonimo quartiere di Città del Guatemala, sullo sfondo della guerra civile) e raccolte di racconti.
- «La metanarrazione si caratterizza per una celebrazione del potere dell’immaginazione creativa insieme a un’incertezza sulla validità delle sue rappresentazioni; per un’estrema autoconsapevolezza riguardo al linguaggio, alla forma letteraria e all’atto di scrivere; per una profonda perplessità circa i rapporti tra la finzione e la realtà; per uno stile parodistico, ludico, esuberante e ingannevolmente ingenuo.» Patricia Waugh, citata da Elzbieta Sklodowska in La parodia en la nueva novela hispanoamericana.
- Per esempio Mildred Hernández, con Orígenes (1995) e Ana María Rodas, che si era già messa in luce come poetessa negli anni Settanta, con Mariana en la tigrera (1996), oltre alle autrici raccolte in un’antologia curata da Lucrecia Méndez de Penedo: Joven narrativa guatemalteca.
- Aida Toledo, La literatura guatemalteca contemporánea y su vocación de herejes: Escritura del exilio, el desarraigo y la nostalgia. Il testo prende in esame in particolare quattro testi emblematici delle ultime tendenze, fra cui Non affrettarti…, a partire da una rilettura critica dell’eredità dei “padri”: Asturias, Monteforte Toledo e Monterroso.
- Emilia Perassi, Premessa a Tradizione, innovazione, modelli. Scrittura femminile del mondo iberico e americano, Bulzoni, Roma, 1996.
- Lucrecia Menéndez de Penedo, La inquietante inocencia en la narrativa de Eugenia Gallardo, in «La Ermita», n. 19, Città del Guatemala, 2000.
- Testo che segna una sorta di implosione del genere biografico, mentre si avvicina maggiormente a un’autobiografia, secondo canoni tutto sommato più tradizionali, I cercatori d’oro, del 1993.
- Aida Toledo, nel saggio già citato, suggerisce di cercare nei testi “marginali” di Asturias – rispetto alle sue opere più note e studiate – le ragioni della sua persistente influenza sugli scrittori delle generazioni successive. E cita in particolare El alhajadito, del 1961, Tres de cuatro soles, del 1971, e El arbol de la cruz, postumo. In questi testi la frammentazione è una caratteristica compositiva centrale.
- Dapprima vi fu quella con García Márquez circa l’originalità di Cent’anni di solitudine, che finì per screditare Asturias, il cui nome non rientrò mai a pieno titolo nel novero di quelli baciati dalla fortuna del boom (né i suoi libri ebbero altrettante traduzioni o riedizioni). In seguito fu attaccato pubblicamente da Roque Dalton per aver accettato il Nobel e l’incarico di ambasciatore a Parigi negli anni 1966-70 da parte del presidente Julio Méndez Montenegro.
- La identidad de la palabra: narrativa guatemalteca a la luz del nuevo siglo (1997). Arturo Arias è uno scrittore guatemalteco che risiede negli Usa, dove insegna all’Università di Redlands, California, ed è presidente del Lasa (Latin American Studies Association); ha pubblicato vari saggi e romanzi, ricevendo due volte il premio Casa de las Américas: per la saggistica con Ideologias, literatura y sociedad durante la revolución guatemalteca 1944-1954, nel 1979, e per la narrativa con il romanzo Itzam Na (dal nome del mitico dio della nobiltà maya abbattuto da una rivolta di contadini), nel 1981. Recentemente ha curato l’edizione critica di Mulata de tal, di Asturias, di cui è appassionato studioso e fine esegeta.
- Il 23 giugno 1994, mediante un accordo siglato a Oslo, nasceva la Ceh (Comisión para el Esclarecimiento Histórico) per indagare sulle violazioni dei diritti umani e sulle violenze ai danni della popolazione guatemalteca. Il rapporto della Ceh, Memoria del silencio, è pubblicato in Guatemala dalla casa editrice presso cui lavora Eugenia Gallardo ed è dispoibile in rete, in spagnolo e in inglese: http://hrdata.aaas.org/ceh/.
- Il libro che le è valso fama internazionale e poi il Nobel per la pace è Mi chiamo Rigoberta Menchu; fu redatto dalla francese Elisabeth Burgos, moglie di Régis Debray, sulla base di nastri registrati. In collaborazione con Dante Llano, la Menchu ha pubblicato in italiano anche La bambina di Chimel, una raccolta di fiabe maya.
- Margarita Carreras, Dos nuevas narradoras: Ana Maria Schlesinger y Eugenia Gallardo, Prensa Latina 9.7.2000.
- In un articolo pubblicato nel supplemento letterario di «El Pais», lo scrittore messicano Carlos Fuentes ha ricostruito un colloquio tra Miguel Ángel Asturias, il cubano Alejo Carpentier e il venezuelano Arturo Uslar Pietri, sulle rive della Senna, nel 1929: «I tre giovani immaginano che, ancora una volta, e ben presto, il romanzo latinoamericano seguirà una moda europea, in questa occasione il surrealismo. Perché mai? Si domandano i tre giovani scrittori. Non siamo forse padroni di un surrealismo originario dell’America Latina?» (Las dos orillas de la modernidad, agosto 2001).
- Parlando della fantasia, la Gallardo scrive: «In altri momenti si lasciò ingannare da un divanetto nero, un vecchio ficcanaso e un bloc-notes» (p. 47).
- Dante Llano, op. cit.
(Postfazione a Eugenia Gallardo, Non affrettarti a raggiungere la Torre di Londra perché la Torre di Londra non è il Big Ben, tr. mia, Fahrenheit 451, 2002)