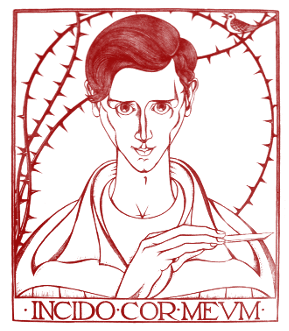Caza de conejos reca in calce la data della stesura: marzo 1973, ma sembra scritto ieri, anzi… domani. Fu pubblicato per la prima volta soltanto nel 1982 in un’antologia: Lo mejor de la ciencia ficción latinoamericana.
Il lettore ha qualche motivo per essere perplesso: fantascienza? Lo stesso Levrero respinse la classificazione, così come l’appartenenza alla letteratura fantastica, e coniò la definizione di “realismo interiore” (un critico lo chiamò “realismo introspettivo”), eppure, a ben vedere, nei suoi racconti compaiono numerose ambientazioni e tematiche tipiche del genere. Per esempio, in Gelatina ci presenta un mondo invaso da una massa gelatinosa che travolge tutto, comprese le relazioni umane tra i sopravvissuti. Nel racconto La sombrilla, in seguito a sconvolgimenti naturali, scompare il mare. Los ratones felices inizia come una favola che ha per protagonisti gli animali (simpatici topolini e un leone beneducato) per trasformarsi – previa assunzione di certe pastiglie – in un infernale e allucinante distopia burocratica. Eccetera.
Continue reading