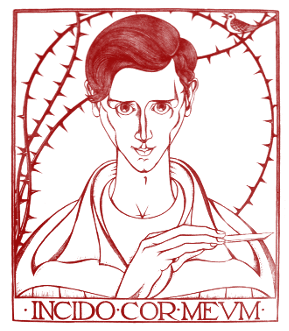Il testo è la trascrizione il più possibile fedele della registrazione dell’intervista che feci a Bolaño alla Fiera del Libro di Torino nel maggio del 2003, pochi mesi prima che morisse. La registrazione fu effettuata nello stand della casa editrice Sellerio, e in qualche punto i rumori di fondo, l’abbassamento di voce o le interruzioni rendono incomprensibili alcune parole o brevi frasi. In questi casi, molto a malincuore, mi sono dovuto arrendere e sono stato costretto a operare qualche taglio. Una versione parziale dell’intervista, un po’ frettolosa per esigenze dei tempi di pubblicazione e ridotta per motivi di spazio, è apparsa sul n. 44 della rivista Pulp libri (con un’aggiunta successiva, nel 2007) e poi sul sito online dell’Archivio Bolaño.
Il testo è la trascrizione il più possibile fedele della registrazione dell’intervista che feci a Bolaño alla Fiera del Libro di Torino nel maggio del 2003, pochi mesi prima che morisse. La registrazione fu effettuata nello stand della casa editrice Sellerio, e in qualche punto i rumori di fondo, l’abbassamento di voce o le interruzioni rendono incomprensibili alcune parole o brevi frasi. In questi casi, molto a malincuore, mi sono dovuto arrendere e sono stato costretto a operare qualche taglio. Una versione parziale dell’intervista, un po’ frettolosa per esigenze dei tempi di pubblicazione e ridotta per motivi di spazio, è apparsa sul n. 44 della rivista Pulp libri (con un’aggiunta successiva, nel 2007) e poi sul sito online dell’Archivio Bolaño.
Molti critici hanno paragonato I detective selvaggi a Rayuela (Il gioco del mondo) di Julio Cortázar. In effetti, oltre a essere entrambe opere con una struttura aperta, presentano assonanze non solo formali. Ti eri forse proposto di scrivere la Rayuela degli anni Novanta?
La mia ammirazione per Cortázar è enorme, appartengo a una generazione cresciuta leggendo Cortázar a diciassette anni, e in un certo momento incarnava il meglio, il punto più alto cui si potesse arrivare. In modo un po’ irrazionale, perché non c’è mai un «punto più alto», e non è nemmeno necessario arrivare a un punto più alto, ma siccome eravamo giovani, e ai giovani si consentono queste esagerazioni e queste grossolanità filosofiche, Cor tázar rappresentava in qualche modo il massimo a cui potevamo aspirare. Con il tempo il mio autore preferito in lingua spagnola è diventato Borges. Cortázar ora è il secondo, diciamo che è un autore che continuo ad amare e a leggere con grande piacere. Per il resto, non si può mai tentare di scrivere un romanzo o un racconto «alla maniera di…», anzitutto perché in qualche misura scrivere «alla maniera di…» implica un parricidio, e io non ho mai visto Cortázar come un padre, ma come una specie di fratello maggiore, nonostante la grande differenza di età. Lui aveva la virtù della gioventù permanente, dell’energia permanente, e anche dell’ingenuità permanente. Io l’ho conosciuto quando avevo ventidue anni, in Messico, e già allora non ero d’accordo con molte sue posizioni politiche, soprattutto per quanto riguarda Cuba, o per quella che Cortázar riteneva dovesse essere la posizione dello scrittore di fronte ai compagni di una determinata lotta politica. Io credo che uno scrittore non debba chiedere il permesso a nessuno per scrivere, tantomeno a dei militanti, che di solito sono quelli che ne sanno meno di queste cose. Ma lui era molto impegnato nella lotta politica, e oltretutto sono convinto che fosse estremamente leale nei confronti del suo impegno – cosa che mi sembra degna di lode – quindi aveva di questi problemi, che io invece non ho mai avuto, in primo luogo perché dai pochi gruppi di sinistra nei quali ho militato sono stato cacciato.
Per tua fortuna…
Per mia fortuna, sì. Tornando all’opera da imitare, o da seguire, o da superare… mai, mai… non c’è mai stata per me un’opera da superare. Sono estremamente modesto rispetto alla mia opera e faccio molta fatica a pensare che I detective selvaggi possa essere paragonato a Rayuela. Per parte mia sarei felicissimo se gli arrivasse al ginocchio, ma credo che non gli arrivi nemmeno al tallone. Poi c’è il discorso sul Cortázar autore di racconti. Non sono mai stato d’accordo con questa specie di falsa dicotomia fra il Cortázar autore di racconti e il romanziere. Io penso che se c’è stato qualcuno al mondo che sapeva come strutturare un libro, dal punto di vista teorico, quello era Cortázar. Ne sapeva molto di più di García Márquez, che scrive quasi intuitivamente, soprattutto se paragonato a Cortázar, e molto di più di Donoso… Vargas Llosa, c’è stato un momento in cui aveva un senso della struttura più o meno chiaro, ma al livello di Cortázar non c’è stato nessuno. La teoria che oppone il Cortázar autore di racconti al Cortázar romanziere è una teoria idiota. Lui sapeva sem pre perfettamente che struttura dare a qualsiasi testo. In questo senso, e per riallacciarsi a Borges, che per me è il più grande scrittore in lingua spagnola dai tempi di Quevedo, c’è un suo racconto che si intitola «L’Aleph» e, come tutti i racconti di Borges, è costruito in maniera esemplare. Vale a dire che racconta una storia, o due storie, ma in qualche modo racconta anche come si costruisce una storia, e in fondo qualsiasi storia. Nell’«Aleph», non so se lo ricordi bene, abbiamo la storia d’amore fra Borges e Beatriz Viterbo, poi c’è una seconda storia: la morte di Beatriz nel fiore della gioventù, appassionata, superba, affascinante… oltretutto muore lasciando Borges con un palmo di naso perché lui non è mai riuscito ad averla in nessun modo. La prima storia è purissima, nella seconda c’è frustrazione, morte, agonia, e un amore non corrisposto. Poi c’è la terza storia: come Borges cerca di far rivivere nei gesti quotidiani il ricordo di Beatriz. E come ci riesce? Andando a visitare la sua casa una volta l’anno. Quarta storia: l’apparizione di Carlos Argentino Daneri, cugino di Beatriz, e la sua successiva amicizia con Borges. Poi viene la quinta storia, e ormai non è più questione di Borges né di Beatriz Viterbo, ma di Carlos Argentino Daneri e dei suoi tentativi come scrittore, come poeta. Quando cita quei versi: «A man diritta del cippo consueto… un ossame s’annoia – Tinta? Biancoceleste». Una cosa spaventosa… Questa è la quinta storia: Carlos Argentino Daneri solo. Poi abbiamo una sesta storia segreta soggiacente che trapela dietro le quinte, vale a dire: Carlos Argentino Daneri come una satira di Pablo Neruda e del suo tentativo di creare un’opera d’arte totale. In quel periodo Neruda stava scrivendo il Canto generale. Carlos Argentino Daneri è, diciamo, il ritratto speculare e assolutamente infernale di Pablo Neruda, il poeta che vuole scrivere tutto. Settima storia: la rivelazione dell’Aleph da parte di Carlos Argentino Daneri. Borges scende e contempla l’Aleph, e diciamo che questa storia è il nucleo principale del racconto. Ottava storia: la vendetta dell’innamorato rifiutato, ergo Borges, sul cugino, che probabilmente aveva avuto una relazione carnale con Beatriz Viterbo. Infine l’ultima storia: la distruzione della casa, che porta con sé la distruzione dell’Aleph, e una nota finale sui destini letterari di Borges e di Carlos Argentino Daneri: Daneri vince un secondo premio a un concorso di poesia e Borges resta a bocca asciutta. Insomma, in un racconto di dieci pagine ci sono già dieci storie, mi dici come cazzo si fa a scrivere un romanzo di oltre seicento pagine con una sola storia? È assolutamente impossibile, chi pensa una cosa del genere è un idiota. Ogni romanzo è un susseguirsi di racconti, di storie che si vanno intrecciando. Stendhal l’aveva già visto con una chiarezza solare, la letteratura, un libro, è uno specchio, ma questo specchio non se ne sta quieto, si muove su una strada, e sullo specchio si riflettono via via le cose che succedono lungo la strada, e ogni cosa può restare in sospeso, con un punto interrogativo, oppure può finire. In questo senso Rayuela di Cortázar, che racconta moltissime storie, non fa che seguire la legge naturale del romanzo. Nemmeno lo scrittore di romanzi più monocorde potrebbe scrivere un romanzo dove vi sia una sola storia. Il romanzo, in questo senso, è un susseguirsi di racconti, perché la vita è un susseguirsi di racconti, tutto nella vita è un susseguirsi di racconti. Di fatto, un anno è il susseguirsi di quattro stagioni, sono già quattro racconti, e un anno non è un anno, in realtà sono quattro stagioni, e un giorno non è un giorno: c’è il mattino, il mezzogiorno, il pomeriggio, il tramonto, la notte. Rimproverare a Cortázar di aver scritto un susseguirsi di racconti denota un’arroganza, e soprattutto un’ignoranza, senza limiti. Perché, che cazzo ha fatto Marcel Proust, o che cazzo ha fatto James Joyce? Un susseguirsi di racconti. E cosa fa un romanziere? Un susseguirsi di racconti… Certo, poi possiamo discutere della struttura, della forma che gli si dà, ma su un piano assoluto non è altro che un susseguirsi di racconti.
Per venire all’ultima parte della tua domanda, sulla genesi del mio romanzo… I detective selvaggi è un romanzo, credo che si noti, molto autobiografico. In pratica quello che faccio è raccontare la biografia mia e di un carissimo amico a un’età nella quale abbiamo smesso di essere giovani, a vent’anni, abbastanza per smettere di esserlo. E insieme è una riflessione, o tenta di sviluppare una riflessione, sul fallimento di una generazione di latinoamericani – e non solo latinoamericani – che in qual- che modo ha creduto nella rivoluzione… e probabilmente, se la rivoluzione in cui credevamo avesse trionfato, saremmo finiti in un gulag. E la cosa non è affatto simpatica (ride). Insomma, sono avvenimenti reali romanzati, alcuni per ottenere maggior verosimiglianza, e altri per ragioni unicamente di ordine estetico.
Anche se i protagonisti del romanzo sono il tuo alter ego Arturo Belano e Ulises Lima, personaggi un po’ sfuggenti…
Sì, e che non compaiono mai direttamente…
…altri personaggi a tutto tondo sono per esempio García Madero e María Font. Mi chiedevo se anche loro sono esistiti realmente e se c’è qualche tratto autobiografico nella figura di García Madero.
García Madero non esiste, María Font sì. L’unico che non è mai esistito in realtà è García Madero, un personaggio simbolico che per me rappresenta la purezza con cui un ragazzo entra nel mondo della letteratura. E che sia simbolico è chiaramente dimostrato – o se ne dà l’indizio – dal fatto che nella parte centrale del romanzo scompare totalmente. Nessuno parla di lui. Com’è possibile che nessuno ricordi l’unico poeta realvisceralista che accompagna Belano e Lima nel viaggio a Sonora? Com’è possibile che assolutamente nessuno parli di lui? García Madero è un simbolo, è il «giovane poeta». Lupe invece, per esempio, la prostituta che resta con García Madero, è esistita davvero, e così le sorelle Font, quasi tutti… È uno dei motivi per cui preferisco non tornare in Messico (ride).
E del tuo alter ego Arturo Belano che ne farai in futuro? Una volta hai minacciato di farlo suicidare… Compare nel romanzo che stai scrivendo?
Nel nuovo romanzo no. C’è in un racconto di Puttane assassine, si trova in Africa, cinque o sei giorni dopo che è scomparso nella foresta insieme a un fotografo madrileno. E si dimostra chiaramente che mentre il fotografo madrileno cercava la morte e l’ha trovata, Belano invece è vivo. È solo, malato, ma vivo. E ho un racconto scritto a metà, in cui Belano fa un viaggio in Messico, tempo dopo, per visitare la tomba di Ulises Lima, che invece è morto. Voglio dire, la persona che chiamo così nel romanzo è morta. Era un poeta, Mario Santiago, il mio miglior amico.
Tu sei cileno, vivi da molti anni in Spagna, hai scritto un grande romanzo messicano, ti muovi a tuo agio in quella che un tempo si chiamava «Patria grande», ma il tuo atteggiamento è molto diverso da quegli intellettuali latinoamericani che ricercano quasi uno statuto da «scrittore nazionale», sorta di «papi laici» pronti ad assumere funzioni ufficiali, istituzionali…
Io credo che fondamentalmente sia soprattutto per paura che García Márquez si vede sempre più come il più grande scrittore colombiano di tutti i tempi, o Vargas Llosa come il miglior scrittore peruviano. Tutti gli scrittori latinoamericani, e penso anche gli spagnoli, in fondo hanno molta paura e cercano di assicurarsi il pantheon post mortem. Io non ho mai avuto paura della morte e inoltre non credo nel pantheon. Io credo che la vita… guarda, quando finisce è finita e non resta niente, perciò io sto con Borges quando disse: Dopo la morte, verrà l’oblio, e molte teste di cazzo gli dicevano: Ma no, Maestro, dopo la sua morte resteranno i suoi libri. Lui li ascoltava e doveva pensare: che bel branco di imbecilli! Perché lui alludeva all’oblio nel senso più ampio del termine, vale a dire: la Terra finirà, il Sole finirà, tutto finirà… L’oblio è un destino comune di tutto, non solo degli esseri umani, e in questo senso gli scrittori latinoamericani che si pongono sempre questo obiettivo che sta fra il clericalismo e la vigliaccheria, be’, cercano di assicurarsi il pantheon post mortem, e il modo migliore per farlo è diventare lo scrittore nazionale di un paese. Carlos Fuentes è un esempio chiarissimo. Se a Carlos Fuentes dicessero ora che alla sua morte non lo seppelliranno nel pantheon degli uomini illustri… Esiste davvero, nel cimitero di Città del Messico c’è un’area speciale chiamata pantheon degli uomini illustri, dove vengono sepolti grandi politici, grandi pittori, grandi scrittori, qualche calciatore, grandi allevatori di bestiame, grandi toreri… be’, se dicessero a Carlos Fuentes che alla sua morte non lo seppelliranno nel pantheon degli uomini illustri, sarebbe capace di fare causa per danni al governo messicano… A me sembra una bestialità. Io invece credo nella povertà intrinseca dell’essere umano. Un animale come siamo noi, provvisto di viscere e muscoli, pochi, ossa debolissime, privo di esoscheletro… Avere lo scheletro dentro invece che fuori mi sembra una cazzata assoluta. Guarda, si muore e finisce tutto, fanculo, non credo nel pantheon degli uomini illustri, e non voglio essere lo scrittore nazionale di nessun posto, e in questo senso non mi preoccupano e non mi hanno mai preoccupato la nazionalità o cose del genere. L’unica cosa di cui mi preoccupo quando scrivo è di salvaguardare una certa verosimiglianza negli idiomi che impiego. Voglio dire: quando parla un peruviano, dev’essere un peruviano che sta parlando, e quando parla un messicano o un centroamericano, dev’essere un messicano o un centroamericano.
Ti renderai conto che si tratta di una sfida micidiale per i tuoi traduttori.
Sì, per i miei traduttori dev’essere un incubo, più che una sfida. Un vero incubo.
Una volta ho letto una tua conversazione con Ricardo Piglia in cui affrontavate il tema delle traduzioni, fino ad arrivare a proporre una enciclopedia biografica di questi «autori invisibili».
È che a Piglia piacciono molto le cattive traduzioni. In questo senso lui segue Roberto Arlt, che è il suo maestro, e Roberto Arlt si formò come autodidatta leggendo bruttissime traduzioni. Quindi Arlt scriveva così come aveva letto i suoi maestri, soprattutto Dostoevskij, e lo aveva letto in pessime traduzioni. Perciò Piglia adora i traduttori, diciamo, arltiani… Credo che sia un suo capriccio, una sua frivolezza, io preferisco avere buone traduzioni, sinceramente.
Un personaggio dei Detective selvaggi a un certo punto dice: Ho smesso di scrivere poesia e da quel momento tutto è diventato molto grigio.
La poesia nei Detective selvaggi è fondamentalmente la metafora della fragilità e della portatilità della letteratura. Non c’è arte più facile – solo all’inizio, dopo diventa la più difficile di tutte – che scrivere una poesia, che fare poesia. Ricordo che a quel tempo in qualche ambiente circolava addirittura l’idea che la poesia potevano scriverla anche quelli che non sapevano scrivere, perché bastava mettere giù parole in libertà. Era un’epoca in cui la poesia d’avanguardia era molto di moda e si associava spesso all’idea di cambiare la vita, e di cambiare vita, e per me fondamentalmente la poesia – perlomeno come la vedevo quando ho scritto I detective selvaggi, è già passato del tempo – è una metafora della fragilità. Una fragilità assoluta. Gente che non solo dal punto di vista letterario, ma anche da quello economico, non aveva futuro, come nello slogan dei punk, era senza futuro e si aggrappava alla poesia, e faceva bene a farlo… però aggrapparsi alla poesia durante un naufragio è come aggrapparsi al tappo di una bottiglia di champagne: non ti terrà a galla. La poesia poi è un’arte portatile: per leggere un romanzo servono tempo e una serie di comodità minime, ma pur sempre comodità, mentre una poesia, un sonetto per esempio, puoi leggerla in mezzo minuto. È molto facile da leggere. Altra storia è capirla, ovvio. Così, per me la poesia quando scrivevo I detective selvaggi era la porta d’ingresso nell’ignoto, e in quella materia sconosciuta, probabilmente, stavo aspettando la vera poesia, ma anche la stessa porta d’ingresso era poesia, una poesia bastarda, poco rigorosa, esagerata…
So che uno dei tuoi poeti preferiti è Nicanor Parra, di certo non Neruda…
Sì, tra i poeti viventi il mio preferito è Nicanor Parra, adoro le sue poesie, ho avuto l’enorme fortuna di conoscerlo personalmente e per me è… guarda, credo di dovergli moltissimo, anche più di quello che io stesso riconosco, e non solo per quanto riguarda la poesia… perché la poesia di Nicanor Parra è una poesia irradiante, come dev’essere la poesia, e irradia non solo verso la poesia, verso l’esercizio poetico, ma verso l’esercizio artistico in generale. È grande poesia… Io credo che Parra sia già un classico.
Ti sei divertito molto a scrivere le pagine sulla metrica, con tutte quelle regole e quei termini alambiccati: il rispetto, lo strambotto…?
Sì, moltissimo. Le ho scritte per divertirmi perché la metrica a volte diventa un atto masturbatorio. Nient’altro. La cosa terribile è pensare che molti studenti di letteratura classica devono impararsi a memoria tutti quei nomi… terribile (ride). Come si può pretendere di insegnare a qualcuno… vabbè, il rispetto e lo strambotto hanno un senso, ma ci sono regole che sono di una gratuità assoluta, assoluta, e poi hanno certi nomi… terrificanti…
Una volta la Mecca degli intellettuali latinoamericani era Parigi, abbiamo l’esempio di Cortázar, ora sembra sia diventata New York. Si ha l’impressione che, pur avendo profonde radici nella tradizione letteraria latinoamericana, tu sappia dialogare anche con altre, in particolare quella nordamericana.
Per essere sinceri, io, come diceva Vittorio Gassman, modestamente, ho letto moltissimo, e da molte letture ho tratto profitto. In questo senso ho debiti nei confronti di parecchie letterature. Non credo che ci sia un’influenza diretta di quella nordamericana, ma sicuramente c’è un’influenza che riguarda di fatto tutti gli scrittori latinoamericani e che proviene dai due rami fondamentali del romanzo nordamericano, che sono i fondatori della tradizione romanzesca del continente americano, ossia Melville e Twain. In questo senso I detective selvaggi ha senz’altro un debito verso Mark Twain. Belano e Lima non sono altro che una trasposizione di Huckleberry Finn e Tom Sawyer. È un romanzo che scorre secondo un moto costante, che è il Mississippi. Insomma, il mio debito verso Twain è enorme, anche perché è un autore che amo e leggo moltissimo. Ho letto molto anche Melville, e mi affascina. In effetti, per civetteria, preferirei credere di essere più in debito verso Melville che verso Twain, ma sfortunatamente penso di dovere di più a Mark Twain. Melville è un autore… apocalittico. Twain è il giorno e Melville la notte, e la notte impressiona sempre molto di più. Ma per quel che riguarda la letteratura nordamericana moderna, la conosco poco e male, molto male. La conosco abbastanza bene fino agli scrittori della generazione precedente a Bellow. Updike l’ho letto abbastanza, ma non so perché lo facessi, sicuramente era un atto masochista, dato che ogni pagina di Updike mi porta sull’orlo dell’isteria. Mailer mi piace molto più di Updike, anche se ritengo che come scrittore, come prosatore, Updike sia più solido. Sta di fatto che la letteratura non consiste nella solidità della prosa, questa è una cosa che si impara in un mese. Credo che gli ultimi scrittori nordamericani che ho letto a fondo e che conosco molto bene siano quelli della «generazione perduta»: Hemingway, Faulkner, Scott Fitzgerald, Thomas Wolff. Mi sento molto più in debito, in qualche misura, verso gli europei, nel senso che le mie prime letture sono state di poesia, e io leggevo soprattutto poeti europei, e passare dalla poesia europea alla narrativa europea è stato facilissimo.
Mi ha colpito, in apertura del tuo romanzo, la citazione da Sotto il vulcano, di Malcolm Lowry. Sei d’accordo che si tratti di un grande «romanzo messicano», nonostante l’abbia scritto un inglese, e in anticipo rispetto al boom latinoamericano degli anni Sessanta? È una tesi sostenuta nel saggio di Francesco Varanini Viaggio letterario in America Latina, che è stato pubblicato anche in Spagna e che forse conosci…
Ho conosciuto personalmente anche l’autore. Ho presentato il suo libro in una università di Barcellona. È un libro che ha ricevuto moltissime critiche, ma io penso che, insieme ad alcuni errori, contiene cose validissime. Quanto a Lowry, assolutamente sì. La citazione è lì proprio per questo. Lowry ha scritto il grande «romanzo messicano», non c’è dubbio.
Un altro aspetto che colpisce dei Detective selvaggi è la polifonia, che mi ha fatto subito pensare a Tre tristi tigri di Guillermo Cabrera Infante, anche perché in entrambi i romanzi si respira un’atmosfera di suspense, di attesa…
Grande libro. A me piace molto Cabrera Infante, e soprattutto questo romanzo, che è il suo capolavoro. Non ti sbagli affatto: se c’è un romanzo polifonico della generazione del boom, è Tre tristi tigri. È indubbiamente il più polifonico di tutti. C’è la lingua parlata dell’Avana, ma non solo. Non so se ricordi quel lunghissimo capitolo sulla morte di Trotzky raccontata da diversi scrittori cubani… Cabrera prende in giro tutti i grandi scrittori cubani, a cui deve molto, ma con un senso dello humour, con un atto di desacralizzazione della scrittura… magnifici.
In una recensione dei Detective selvaggi ho letto un commento che mi sembra azzeccato dove si parla della «prospettiva di fuga» che prevale nel romanzo, dove tutti fuggono: la prostituta Lope, i due protagonisti, l’anziana poetessa messicana, forse persino i ricordi di una generazione…
In questo ha molti punti di contatto con Rayuela. Rayuela è il romanzo di una fuga, quella di Oliveira. Questo non succede in Tre tristi tigri, dove c’è piuttosto uno stare, un vivere le cose che succedono via via all’Avana. È molto più sensuale, in questo senso… lasciare che le cose succedano, e godere del momento. Carpe diem. I detective selvaggi è un romanzo di fughe, questo è chiarissimo. Per esempio, María Font nel diario di Madero è una donna piena di vita e vogliosa di fare tante cose, ma nella seconda parte, via via che passa il tempo, si va richiudendo sempre più su se stessa, fino all’isolamento totale. È una sfida al mondo… E il padre di María Font, Quim, che finisce in manicomio, e oltretutto non in una clinica privata ma in un manicomio statale, e tu non hai idea di cosa sono i manicomi in Messico… spaventosi. Mi ricordo che passavo di lì in autobus, durante un periodo in cui lavoravo in un posto lì vicino, e l’autobus passava accanto a questo manicomio statale. C’era un’enorme rete metallica sormontata dal filo spinato, e i pazzi vagavano come nel film La notte dei morti viventi di George Romero. Era impressionante, impressionante… Faccio fatica a descriverlo.
Hai preso dalla realtà anche Quim Font, il padre di María?
Sì…
E ha avuto lo stesso destino del personaggio del romanzo?
No, abbastanza migliore… e insieme abbastanza peggiore. Credo che il destino migliore di Quim Font, della persona che nel mio romanzo si chiama Quim Font, sarebbe stato quello del personaggio, molto più radicale, più degno… Lui invece è finito in un modo meno radicale, meno doloroso, ma molto più indegno. Io credo che nel romanzo a un certo punto Quim Font si rivela un personaggio molto importante ed esprime un’enorme dignità, quando è ormai rimasto senza niente, appare veramente come una sorta di eroe…
E per concludere questa intervista, so che fra gli scrittori latinoamericani contemporanei che senti affini c’è l’argentino Rodrigo Fresán. Ci sono altri con i quali ti senti in consonanza o di cui ti piace il lavoro?
Sì, Rodrigo Fresán è mio amico e sta scrivendo cose interessanti. C’è un altro argentino, che sento molto vicino, Alan Pauls, poi ci sono i messicani Daniel Sada, che è difficilissimo da leggere ma che a me piace molto, e Carmen Boullosa, di cui sono molto amico. C’è il guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, forse attualmente il migliore autore di racconti, lo stilista numero uno della mia generazione. Anche lui mi piace moltissimo. Il Guatemala è un paese estremo, nessuno dovrebbe scrivere, dovrebbero essere tutti analfabeti… c’è una miseria, una violenza che fa rizzare i capelli in testa, sembra una situazione senza vie d’uscita. Eppure ogni trenta o quarant’anni tira fuori uno scrittore straordinario: prima Miguel Ángel Asturias, poi Arturo Monterroso, oggi c’è Rodrigo Rey Rosa.