Non si può certo dire che l’editoria italiana si sia disinteressata della letteratura di Santo Domingo. Negli ultimi quindici anni sono stati pubblicati due romanzi di Junot Díaz (La breve favolosa vita di Oscar Wao e È così che la perdi, tr. di Silvia Pareschi, Mondadori 2009 e 2013) e parecchi di Julia Álvarez, fra cui Il tempo delle farfalle (tr. di Luisa Corbetta, Giunti 2006) e Liberi domani (tr. di Maurizio Bartocci, Mondadori 2004). Inoltre: Marcio Veloz Maggiolo (La biografia diffusa di Sombra Castaneda, tr. di Tiziana Gibilisco, Perosini 2001) e Riti di cabaret (tr. di Francesca Sammarco, Besa 2001), e Ángela Hernández Núñez (Come raccogliere l’ombra dei fiori, a cura di Danilo Manera, Perosini 2001). Manera ha curato anche due antologie di racconti: I cactus non temono il vento, Feltrinelli 2000, e Onde, farfalle e aroma di caffè, Edizioni Estemporanee 2005.
Ora la neonata casa editrice NNE propone I gatti non hanno nome, di Rita Indiana Hernández, nella traduzione di Vittoria Martinetto, e per una volta non si tratta dell’ennesima variazione sul tema della dittatura di Trujillo, leitmotiv della letteratura dominicana della seconda metà del Novecento.
La voce narrante della storia, ambientata a Santo Domingo negli anni Novanta, è una ragazzina di quattordici anni che nel romanzo non ha un nome, così come non ce l’ha il gatto che accudisce nella clinica veterinaria dello zio Fin, e la ricerca del nome per l’animale finisce per alludere a quella della sua identità.
I genitori sono in vacanza e lei condivide con zio Fin e zia Celia, oltre alla gestione della clinica, i segreti di famiglia: lo zio, neoconvertito al buddismo con un passato da viveur, ha avuto un figlio da una portoricana, e la zia ha fatto carriera come architetto grazie a un parente ben introdotto nel partito del caudillo Balaguer. In secondo piano, ma non per questo meno rilevanti, la nonna, meritevole di rispetto nonostante stia perdendo il senno, e il figlio di zio Fin, che si presenta a diciott’anni per conoscere il padre scatenando una piccola bufera domestica.
Il tono prevalente è quello umoristico, anche se non mancano slanci lirici ed episodi dolorosi, come la morte di Armenia, la vecchia serva haitiana, e il piccolo dramma della protagonista verso la fine del romanzo. E fin qui la freschezza degli aneddoti, alcune felici similitudini e la spontaneità del linguaggio colloquiale – che in realtà implica un fine lavoro di cesello –, insieme alla simpatia che suscita l’innocenza della protagonista, indurrebbero a classificare I gatti non hanno nome come un romanzo light intriso di cultura pop, ideale per lettori adolescenti.
Ma c’è dell’altro, e si tratta di qualcosa che può sfuggire al lettore italiano ignaro del contesto storico e delle ataviche problematiche della società dominicana, anzitutto il razzismo e i secolari dissidi con gli haitiani.
La stragrande maggioranza della popolazione di Haiti, discendente dagli schiavi deportati dagli spagnoli dopo che il vaiolo aveva decimato l’etnia indigena dei taino, ha conservato caratteristici tratti africani, mentre nella Repubblica dominicana è prevalsa la commistione con i bianchi. Vale anche la pena ricordare che Haiti proclamò la propria indipendenza dalla Francia nel 1804 – la prima repubblica nera del mondo –, dopo una lunga e sanguinosa lotta per l’abolizione dello schiavismo. La successiva epurazione etnica di gran parte dei bianchi rimasti nell’isola, insieme alle continue guerre fra i due Stati che vi convivono – la Repubblica dominicana ottenne l’indipendenza solo nel 1844, liberandosi proprio dal dominio di Haiti – offrì il destro, nel 1937, al dittatore dominicano Trujillo di/per scatenare un’analoga mattanza contro gli haitiani, tanto che il fiume che divide i due paesi fu rinominato Rio Masacre . L’odio di Trujillo per Haiti divenne un’ossessione – lui stesso era di origini haitiane, il che lo costringeva a usare creme sbiancanti – e fu lui a fondare un vero e proprio razzismo di Stato tuttora vigente al di là delle ipocrite dichiarazioni di facciata, come dimostra una legge fortemente discriminatoria approvata nel 2013.
Ebbene, Rita Indiana, che nella vita pubblica è in prima fila nella lotta contro il razzismo e tutte le forme di discriminazione, nel romanzo introduce il tema in modo obliquo, attraverso la percezione che dell’«altro» ha la protagonista, bianca e di buona famiglia.
Radamés, personaggio chiave del romanzo secondo la critica più avveduta, è un giovane haitiano immigrato illegalmente che fa qualche lavoretto nella clinica, ma all’inizio lei – che ha ereditato i pregiudizi familiari, sociali e razziali – si vergogna di presentarsi in sua compagnia in un ristorante cittadino: «Immaginavo le risatine e le espressioni schifate con cui avrebbero detto il mio nome e poi “haitiano”». Poi però riesce a vedersi con gli occhi di Vita, un’amica italiana che le piace molto: «Per lei, Radamés e io eravamo uguali», e alla fine, dopo aver vinto la propria diffidenza e simpatizzato con il ragazzo, deve ammettere che «ha stile senza sforzarsi granché». E sarà proprio lui, che ha l’occhio lungo, a rivelarle le sue preferenze per lo stesso sesso: «Devi esere più dolce con la fem, se vuoi la fem».
Un romanzo di formazione, dunque, la cui protagonista, grazie alla sua sensibilità e a una mentalità solidale, malgrado le pulsioni omicide che sublima in semplici fantasie, scopre il valore e la profonda umanità del «diverso».
Rita Indiana, classe 1977, ha fatto parlare di sé fin dall’esordio nel 2000 con La estrategia de Chochueca, le avventure notturne di Silvia, una diciassettenne ribelle, annoiata e disillusa, e dei suoi amici – veri flâneur tropicali fra cui un sanki, come vengono chiamati gli gigolò nei Caraibi –, che si arrabattano tra furtarelli, traffici di droghe e carte di credito, rave e dipendenza da Internet, lottando contro una società puritana e machista che li emargina.
Cinque anni dopo ha pubblicato Papi, la cui voce narrante è quella di una bambina di otto anni affascinata dalla figura del padre, un mafioso sempre assente che nella sua nostalgia assume dimensioni titaniche: «Perché il mio papà non è qui? Perché è un Dio e ha un mucchio di cose da fare». L’autrice ha dichiarato che Papi è risultato più autobiografico di quanto desiderasse: come il protagonista del romanzo, infatti, suo padre fu assassinato a New York in circostanze misteriose quando lei aveva dodici anni.
Dopo Papi e prima di Nombres y animales (2013), titolo originale di I gatti non hanno nome, Rita Indiana ha intrapreso una carriera musicale di successo sulla scena underground caraibica con il gruppo dei Misterios, proponendo un sound innovativo, una sorta di fusion fra merengue, ritmi tropicali, hip-hop ed elettronica, con testi che muovono dalla stessa fonte d’ispirazione della sua narrativa. Dopo il devastante terremoto che ha colpito Haiti nel 2010, ha polemizzato con il celebre predicatore televisivo statunitense Pat Robertson, secondo il quale la tragedia era frutto di un patto col diavolo stipulato al momento della nascita della nazione, evocando un altro spauracchio che è sempre servito a emarginare gli haitiani: il vudù. Ma la vera magia nera, per Rita Indiana, è quella subita dal popolo haitiano a partire dall’embargo imposto al paese dalle potenze imperialiste e dall’indennizzo richiesto dalla Francia per la concessione dell’indipendenza, e poi con un secolo di lavori forzati e di maltrattamenti. Attualmente Rita Indiana è finalista del premio Vargas Llosa, che sarà assegnato in aprile, con il suo ultimo romanzo, La mucama de Ominculé.
(Versione originaria e integrale del pezzo pubblicato su Alias)
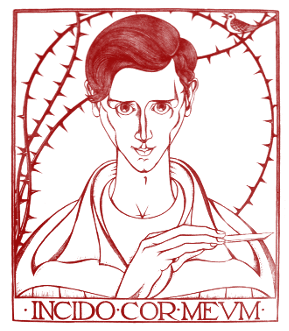

Pingback: NNEDITORE | Rassegna Stampa on line di Rita Indiana